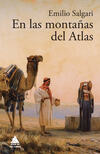Read the book: «La città del re lebbroso», page 5
«Fino a dove rimonteremo il Menam?»
«Fino ad Ajuthia, dove incroceremo e risaliremo, finché sarà possibile, il Nam-Sak. Venite a cenare, dottore. Tracceremo meglio il nostro itinerario.»
Si erano già alzati, quando verso la stessa finestra di prima udirono degli scricchiolii, come se altri rami si spezzassero, poi un fruscio di foglie e infine un colpo sordo. Si sarebbe detto che un corpo umano si fosse lasciato cadere nel giardino.
Lakon-tay si precipitò nuovamente verso la finestra, tenendo in mano una pistola dalla canna lunghissima ed arabescata, che aveva preso da una mensola.
«Ci spiavano!» gridò.
Il dottore lo aveva seguito, infilando le mani nell’alta fascia di seta rossa che portava sotto la giacca di flanella bianca, e nella quale teneva forse qualche arma.
La luna cominciava allora ad apparire sulle cime delle foreste circondanti la città, ma fra le aiole e nei viali del giardino non si scorgeva alcun essere umano.
«Eppure qualcuno o qualcosa è caduto,» disse Lakon-tay, con inquietudine.
«Che qualche scimmia sia entrata nel vostro giardino e si sia arrampicata fin qui?» chiese il dottore. «Ne ho veduto parecchie nei giardini confinanti col vostro.»
«Può darsi,» rispose il generale, facendo un gesto di dubbio. «Manderò Feng e qualche altro servo a visitare il giardino. Andiamo a cenare, dottore: è già tardi.»
Capitolo VIII. L’agguato
Si erano appena ritirati, quando un’ombra umana si alzò in mezzo ad una folta aiola di peonie di Cina, scivolando rapidamente verso la cancellata che cingeva il giardino.
Era un uomo quasi interamente nudo, non avendo che un cortissimo sottanino stretto ai fianchi; la sua pelle, assai bruna, luccicava come se fosse stata unta recentemente con olio di cocco.
Sospeso ad una sottile cintura, portava uno di quei coltellacci dalla lama larga e dalla punta quadra usati dai Birmani e dai Cambogiani, arma terribile, che d’un sol colpo tronca la testa sia ad un uomo che ad una belva.
Quell’individuo, che pareva dotato di un’agilità straordinaria, si inoltrò tenendosi sotto l’ombra proiettata dagli alberi, che crescevano numerosi nel giardino, raggiunse la cancellata, vi si inerpicò scavalcando le punte senza ferirsi e con un rapido volteggio si lasciò cadere sulla riva del Menam.
Aveva appena eseguito quella manovra, quando vide una torcia apparire all’estremità del giardino.
«Se tardavo un po’, mi prendevano,» mormorò. «Ora inseguitemi, se ne siete capaci. Kopom ha i garretti solidi e sfida i cervi.»
Si slanciò a corsa sfrenata, tenendosi curvo verso terra e seguendo la riva del fiume, che in quel luogo era ombreggiata da una doppia fila di alberi di cocco, dalle immense foglie piumate.
Continuò a correre per una decina di minuti, poi, quando si credette sufficientemente lontano dalla palazzina del generale, accostò alle labbra un piccolo pi, traendone alcune note stridenti e acutissime.
Dopo alcuni istanti, verso la riva opposta, si udì rullare un tong, poi una barca lunghissima, stretta, colla prua alta e affilata, montata da alcuni uomini, se ne staccò, scivolando silenziosamente sulle acque del maestoso fiume.
Non aveva alcuna lanterna di carta oliata a bordo, né alcuna doratura sui fianchi. Era una di quelle lunghe canoe scavate col ferro e col fuoco nel tronco d’un albero gigantesco, adorna sul davanti di una testa di drago e guidata da una pagaia di dimensioni straordinarie che serviva da timone.
Otto paia di remi la spingevano rapidissimamente, essendo i Siamesi battellieri insuperabili.
In dieci minuti attraversò il fiume, che in quel luogo era larghissimo, e approdò dinanzi a una capanna semidiroccata, che un tempo doveva aver servito d’asilo a qualche pescatore.
Un uomo solo, corpulento, le spalle avvolte in una larga sciarpa di seta nera che gli nascondeva parte del viso, scese sulla riva.
Era Mien-Ming, il possente puram segreto del re.
«Sei riuscito?» chiese a Kopom che gli era mosso incontro.
«Sì, mio signore,» rispose il Cambogiano.
«Hai udito tutto?»
«Tutto, ma per poco non sono stato sorpreso; le piante che coprono la facciata della phe per due volte hanno ceduto sotto il mio peso, e sono sfuggito alla morte per un vero miracolo, giacché il generale si era armato d’una pistola.»
«E non t’ha scorto?»
«No, perché mi sono tenuto fermo contro il muro, ammassando sopra di me le foglie. Se in quel momento un altro ramo si fosse spezzato, non so se sarei qui a raccontarti l’esito della mia pericolosa impresa.»
«Che cos’hai udito?» chiese il puram con vivacità.
«Partono domani, dopo il mezzodì.»
«Chi partono?»
«Il generale e anche Len-Pra.»
Una rauca bestemmia sfuggì dalle labbra contratte del puram.
«Anche Len-Pra, hai detto?» chiese con voce sibilante. «Ne sei certo?»
«Ti dirò anche, signore, che la conduce con sé per impedire a te di rapirla.»
Il puram era diventato pallido.
«Che sospetti di me?»
«Non lo so, padrone.»
«Anche per la morte dei S’hen-mheng?»
«Di ciò non ha parlato.»
«Ma teme che io approfitti della sua assenza per rapirgliela?»
«Sì, padrone.»
Il puram fece un gesto di furore.
«Avrò dunque inventato la storia del sogno inutilmente?» esclamò, digrignando i denti e camminando come una belva feroce lungo la riva del fiume. «Ah! Conduce con sé Len-Pra! La vuole esporre ai pericoli di quel lungo viaggio per impedirmi di rapirgliela! La portasse anche in Cina, Mien-Ming non rinuncerà ai suoi progetti.
Quella fanciulla mi ha stregato e bisogna che diventi mia, dovessi scatenare una rivoluzione nel Siam e ucciderle il padre.
Non mi conosci ancora, Lakon-tay, e non sai di che cosa sono capace io! Hai osato rifiutare la mano di Len a me, puram, l’uomo più potente e più temuto del regno dopo Phra-Bard? Imbecille! Me la pagherai cara!»
Dopo quello sfogo violento, Mien-Ming tornò verso il Cambogiano, che non aveva lasciato il suo posto.
«Hai altro da dirmi?» gli chiese.
«Sì, padrone,» rispose Kopom.
«Parla.»
«Un uomo bianco, un europeo, accompagnerà Lakon-tay.»
«Chi è?» chiese Mien-Ming, aggrottando la fronte.
«Quel dottore di cui ti ho parlato,» rispose Kopom.
Il viso del puram assunse un’espressione d’odio terribile.
«Quel medico che tu, per molte sere, hai sorpreso in atto di scambiare sguardi con Len-Pra?» chiese.
«Sì, puram.»
Mien-Ming strinse i pugni, come se volesse stritolare qualcosa.
«Ecco un uomo che bisogna sopprimere,» disse poi con voce cupa.
«Un europeo?»
«Fosse anche un principe, un re od un demonio, quell’uomo non seguirà Len-Pra, né Lakon-tay nell’alto Menam. È rientrato nella sua palazzina?»
«Non ancora, padrone.»
«Hai paura tu?»
«Ti ho dato già molte prove di essere coraggioso.»
«Quanti uomini vuoi?»
«Quattro mi basteranno.
«Hai il coltellaccio?»
«Eccolo,» disse Kopom, facendo scintillare alla luce della luna la larga lama tagliente come un rasoio.
«Bisogna però che nessuno se ne accorga.»
«Lo attirerò in qualche luogo deserto. Egli è un medico e non sì rifiuterà di prestare aiuto ad un moribondo.
Se io lo assalissi presso la phe di Lakon-tay, le sue grida attirerebbero i servi del generale e fors’anche il generale stesso.»
«Come agirai?»
«Lascia fare a me, puram; ho il mio progetto,» disse il Cambogiano, sorridendo. «Sarà ben bravo se mi sfuggirà.»
«Sii prudente: io ti seguirò da lontano, pronto a proteggerti colla mia autorità, nel caso che sopraggiungesse qualche guardia notturna.
Tu sai come io ricompenso i tuoi servigi, e ti ho promesso di farti diventare un giorno mandarino e di appagare la tua ambizione.»
«Lo so, padrone: la tua protezione vale quanto quella del re. Farò molta strada,» concluse il briccone, con un tristo sorriso.
Mien-Ming si accostò alla scialuppa, scambiando alcune parole coi battellieri.
Quattro abbandonarono tosto i banchi e balzarono a terra, cacciandosi entro le fasce dei coltellacci simili a quello che aveva il Cambogiano. Erano uomini robusti, tarchiati, dalla tinta fosca, gli occhi obliqui col bulbo giallo, e indossavano una semplice camicia di cotone grossolano che scendeva fino alle ginocchia.
Kopom li guardò attentamente ad uno ad uno, poi, soddisfatto da quell’esame disse: «Ecco dei bei tipi di Malesi, che valgono come dieci Siamesi.»
«Uomini senza scrupoli e dalla mano pronta,» rispose Mien-Ming. «I miei uomini non li recluto che fra i Malesi o i Cambogiani.»
«Addio, padrone, e conta su di me,» disse Kopom.
Risalì la riva seguito dai quattro battellieri e si diresse con passo rapido verso la phe del generale. Quando giunse nella via che separava le due palazzine, si volse verso i Malesi, dicendo loro:
«Andate a nascondervi dietro quel muricciolo e, quando mi vedrete assieme all’uomo bianco, mi seguirete senza farvi scorgere.
Non assalite se prima non udite il fischio del mio pi.
Vi sono cento tical da guadagnare, che il padrone pagherà senza battere ciglio.»
I quattro banditi scomparvero dietro il muricciolo.
Kopom si collocò presso un angolo della palazzina del dottore e si mise a guardare attentamente le finestre della phe di Lakon-tay, le quali erano ancora illuminate.
«L’uccello è ancora lì dentro,» mormorò. «Il puram sarà contento! Io un giorno sarò mandarino, e poi, col tempo, chissà, puram del re anch’io. Gli affari vanno a meraviglia.»
Il Cambogiano era un briccone che per ambizione, per doppiezza e per scaltrezza valeva Mien-Ming.
Era anch’egli un avventuriero, come ve ne sono tanti in quei paesi, senza fede e senza legge, il quale non aveva che un solo scopo: quello di salire in alto.
Aveva cominciato la sua carriera come mahut, ossia conduttore di elefanti alla corte del re di Cambogia, e si era fatto subito distinguere per la sua abilità, per il suo coraggio e soprattutto per la sua furberia. Malgrado però tutti i suoi sforzi, temeva di finire la sua carriera ed i suoi sogni di grandezza fra gli elefanti reali, quando un avvenimento inatteso gli permise di montare il primo gradino.
Il S’hen-mheng del re di Cambogia, il solo che possedeva, perché in quel paese i colossi di quella tinta biancastra sono molto più rari che nel Siam, dopo venticinque anni era morto d’indigestione.
Il re, desolato e spaventato, dopo aver speso invano somme enormi per farne cercare un altro, si rivolse a Phra-Bard il quale, più fortunato, ne possedeva in quell’epoca ben sette, che godevano tutti una eccellente salute.
Malgrado gli offrisse tesori favolosi, il re del Siam rispose con un rifiuto categorico.
Arse d’ira il monarca Cambogiano, e nel suo cuore giurò la distruzione dei S’hen-mheng Siamesi!
Aveva avuto campo, in parecchie occasioni, di apprezzare l’abilità, il coraggio e la scaltrezza di Kopom, e gli diede l’incarico di vendicarlo, promettendogli una somma ragguardevole e la sua protezione.
Munito di raccomandazioni potenti, Kopom riuscì così a farsi accettare, senza troppe difficoltà, fra i servi della corte degli elefanti bianchi del re del Siam, e subito cominciò la sua opera di distruzione.
Un mese dopo il primo S’hen-mheng, il più bello ed il più robusto, colpito da una malattia misteriosa che lo faceva deperire ogni giorno di più, era già cadavere.
Invano i medici Siamesi cercarono le cause di quella morte strana. Un solo uomo però indovinò che il veleno non doveva essere stato estraneo alla fine del povero elefante: Mien-Ming, che nella sua qualità di Cambogiano era maestro in fatto di veleni.
Il puram si guardò bene però di suscitare qualsiasi sospetto nell’animo del re, perché quella morte favoriva i suoi disegni.
Era in quell’epoca che Lakon-tay, governatore della corte dei S’hen-mheng, l’aveva rifiutato come sposo della dolce Len-Pra, e nell’anima bieca del puram era nato un odio profondo, inestinguibile contro il valoroso generale.
Il puram si propose perciò di sorvegliare personalmente il suo compatriota, ed una notte, nascosto dietro una colonna della immensa sala nella quale i guardiani dormivano, scoperse Kopom nel momento in cui stava versando, nel vaso d’argento colmo d’acqua d’un elefante, il contenuto d’una fiala.
Il puram avrebbe potuto, con una semplice parola, perdere l’avvelenatore; invece lo risparmiò perché, come abbiamo detto, la distruzione dei S’hen-mheng doveva segnare la caduta di Lakon-tay. Gli promise di non denunciarlo e fece dell’avvelenatore la sua anima dannata, facendogli balenare la speranza di farlo creare un giorno mandarino.
Come abbiamo veduto, il Cambogiano aveva ottenuto per parte sua il suo scopo, vendicandosi del rifiuto del generale; e Kopom era salito di un altro gradino, sotto la potente protezione del puram, che stimava ben più sicura di quella del re di Cambogia, dal quale non aveva ottenuto, per l’eccidio degli elefanti, che una somma non troppo elevata, nessuno degli onori promessi…
Il briccone si trovava nascosto dietro l’angolo della palazzina da una buona mezz’ora, e cominciava già ad impazientirsi, quando vide la porta della phe di Lakon-tay aprirsi ed uscire l’europeo.
Il Cambogiano attese che avesse attraversato la via, che a quell’ora era deserta, poi, uscendo rapidamente dall’ombra, lo raggiunse, prima che avesse il tempo di salire i tre gradini della palazzina e di percuotere il gong.
Roberto, udendo quell’uomo accostarsi, si voltò bruscamente, con una mano entro la larga fascia, chiedendogli:
«Che cosa vuoi?»
«Sei tu il medico bianco che guarisce gli ammalati?» chiese Kopom, con voce gemente.
«Sì, sono io.»
«La mia donna sta per morire, signor uomo bianco, e mi hanno detto che tu solo puoi salvarla. Io sono un povero battelliere, ma se tu riesci a conservarmela in vita, ti fornirò di pesce tutto l’anno.»
Il dottore a quella strana promessa sorrise.
«Conserva il tuo pesce per la tua famiglia,» gli disse. «Dove abiti?»
«Presso il fiume.»
«Lontano?»
«Cinquecento passi.»
«Precedimi, quantunque sia un po’ tardi.»
«Grazie, signor uomo bianco,» disse il briccone, fingendosi profondamente commosso. «Sommona Kodom pregherà per te, uomo generoso.»
«Lascia in pace Budda e spicciati.»
Il Cambogiano invece di precederlo gli si mise al fianco allungando il passo.
Con un rapido sguardo si assicurò che i quattro Malesi avevano lasciato il muricciolo e che lo seguivano silenziosamente, tenendosi sotto la cupa ombra dei tamarindi e degli alberi di cocco che fiancheggiavano la via.
L’italiano, il quale di nulla sospettava, e aveva creduto alle parole di quell’uomo che aveva scambiato per un povero battelliere del Menam, lo seguiva, immerso nei suoi pensieri.
Il Cambogiano si dirigeva verso il fiume e precisamente verso la capanna abbandonata, pensando che in caso di bisogno avrebbe potuto far accorrere anche i battellieri della scialuppa. Stava per discendere la riva, quando finse di fare un passo falso, lasciandosi cadere al suolo.
Il dottore si curvò per aiutarlo a rialzarsi; ma ad un tratto si sentì stringere il collo da due mani nervose, mentre nell’oscurità echeggiava un fischio.
Il Cambogiano con una mossa fulminea l’aveva afferrato e lo teneva stretto, per lasciar tempo ai Malesi di accorrere.
«Che cosa fai, canaglia?» gridò l’italiano con voce strozzata.
«Accorrete: lo tengo, lo ten…»
Il Cambogiano non poté finire la frase.
Il dottore era robusto ed aveva una muscolatura d’acciaio. Con un pugno ben applicato, schiacciò il naso del ribaldo, poi, svincolatosi bruscamente, con una poderosa pedata lo mandò a ruzzolare fra i canneti del fiume.
«Prendi, birbante!» gridò.
Poi con un salto si slanciò sul margine della diga, per rimontare la via che costeggiava il fiume.
Solo allora s’accorse che il battelliere non era solo. I quattro Malesi stavano per precipitarglisi addosso, tenendo in pugno i larghi e terribili coltellacci Birmani.
«Ah… Volete assassinarmi!» gridò il dottore.
Cacciò le mani entro la fascia che portava sotto la giacca e le ritrasse stringendo in ognuna una pistola.
Due lampi balenarono, seguiti da due detonazioni e da due rantoli.
Due uomini caddero l’uno sull’altro, senza mandare un grido; gli altri, dopo una breve esitazione, si precipitarono all’impazzata giù per la riva, balzando nel fiume e scomparendo sott’acqua.
Il dottore, ancora sorpreso da quell’aggressione ingiustificabile, era rimasto sulla cima della discesa per vedere se i due uomini tornassero a galla, quando, nel volgere gli sguardi verso la capanna, scorse altre persone che salivano cautamente la riva.
Immaginandosi che fossero altri compagni del battelliere e trovandosi colle pistole scariche, stimò prudenza battere precipitosamente in ritirata.
Se aveva delle braccia solide, aveva anche delle gambe buone. In due salti raggiunse la via che costeggiava la riva e si slanciò verso la sua casa, che non era lontana più di cinque o seicento metri.
Già non distava che qualche centinaio di passi, quando vide due uomini muniti di lanterna di carta oliata corrergli incontro.
Si arrestò, indeciso sul da farsi, credendoli nuovi avversari, quando una voce a lui ormai ben nota gridò:
«Veniamo in vostro soccorso, dottore!»
Erano il generale e Feng, entrambi armati di fucile e di catane.
«Siete voi che avete fatto fuoco?» chiese Lakon-tay, con voce alterata.
«Sì, generale,» rispose Roberto.
«Contro chi?»
«Contro degli uomini che avevano tentato di assassinarmi, dopo avermi attirato verso il fiume.»
«Dalla veranda vi avevo veduto parlare con un uomo, poi allontanarvi, quindi ho udito due colpi di pistola.
Credendo che foste stato voi, sono accorso. Chi può avervi preparato un agguato? E poi, assalire un europeo!… Un simile caso non è avvenuto mai in Bangkok.»
«Non si dirà più così,» rispose Roberto, sorridendo. «Me la sono cavata bene e ho ucciso due dei miei aggressori.»
«Chi erano?»
«Mi parvero battellieri o pescatori.»
«Andiamo a vederli. Abbiamo due buone carabine e le catane e nessuno oserà affrontarci. Avete mai avuto questioni con qualche battelliere?»
«Mai, generale.»
«Che quei miserabili vi abbiano assalito per derubarvi?»
«Lo suppongo.»
«O che ci sia sotto la mano di qualcuno dei miei nemici?»
«A quale scopo?»
«Non so, forse per impedirvi di seguirmi.»
«Se fosse così, hanno completamente fallito il loro scopo.»
Si misero in cammino, dirigendosi verso il fiume, preceduti da Feng, il quale rischiarava la via e teneva la carabina armata.
In pochi minuti giunsero sulla riva del Menam. Per non cadere in una imboscata scesero a ispezionare la capanna e la trovarono deserta.
Anche sulla riva non si scorgeva alcun essere umano.
«Avranno avuto una barca nascosta fra i canneti e avranno attraversato il fiume,» disse il dottore.
«È probabile,» rispose Lakon-tay.
Risalirono la riva per cercare i due cadaveri; anche quelli erano scomparsi. I loro compagni, per evitare che i due morti potessero venire riconosciuti, dovevano averli portati via e gettati nel fiume.
Si vedevano invece sulla sabbia due larghe macchie rosse e l’impronta di numerosi piedi nudi.
«Non potremo sapere nulla,» disse il dottore. «Che il diavolo se li porti, e che…»
Si interruppe, prendendo per mano il generale.
«Vi ricordate del rumore che abbiamo udito presso la finestra, quando eravamo nella vostra stanza?»
«Sì,» rispose il generale, «ed aggiungo che ora sono convinto che qualcuno abbia udito i nostri discorsi.»
«Era possibile una scalata?»
«Sì, essendo la facciata della casa coperta di piante rampicanti, abbastanza robuste per reggere il peso di un uomo.»
«Ci hanno spiati.»
«Ne sono convinto anch’io.»
«E a quale scopo?»
«Per conoscere i miei progetti. Quando hanno saputo che voi mi accompagnerete hanno cercato di sopprimervi.»
«Non ne capisco il motivo.»
«Nemmeno io per ora; ma chissà che un giorno non riusciamo a capirlo.»
«Andiamo, dottore, vi scorteremo fino alla porta della vostra casa e domani faremo i nostri preparativi.»
Capitolo IX. Sul Menam
A mezzodì, dopo aver pranzato in compagnia, Lakon-tay ed il dottore a piedi e Len-Pra in palanchino lasciarono la phe, avviandosi verso il fiume.
Premeva loro abbandonare la città prima che quei misteriosi nemici rinnovassero contro il dottore l’attentato che per poco non aveva avuto terribili e irreparabili conseguenze.
Nella mattinata avevano tutto preparato per quel lungo viaggio, che poteva durare moltissimi mesi, in regioni assolutamente selvagge e popolate da tribù bellicose, poco ben disposte verso gli stranieri in generale e verso i Siamesi in particolare.
Il balon, ossia la grande scialuppa del generale, era stata fatta venire dal cantiere dove era stata inviata in riparazione qualche settimana prima, e Feng, che aveva ricevuto tutte le istruzioni, l’aveva equipaggiata con gente scelta e robusta e fornita di tutto il necessario occorrente per quella pericolosa spedizione: viveri, armi, vesti di ricambio, coperte, tende ed altre cose ancora, suggerite dal dottore che non era nuovo ai lunghi viaggi.
Roberto aveva indossato un nuovo costume di leggera flanella bianca, si era strette le gambe entro alte uose di cuoio per difenderle dai morsi dei serpenti, numerosi non meno che nell’India e nelle foreste Siamesi, e riparato il capo da un casco di midolla di bambù coperto di tela, leggero e ottimo riparo contro i colpi di sole.
Lakon-tay, che apprezzava la praticità dei vestiti europei, aveva rinunciato senza rimpianti alle sue camicie, alle sue fasce di seta ricamate e alle sue babbucce dalla punta rialzata, assolutamente inefficaci a riparare i piedi dalle erbe dure e talvolta taglienti delle foreste, per indossare un costume simile a quello del dottore.
Ad una cosa sola non aveva rinunciato: all’alto cappello conico in forma di pagoda, col cerchio d’oro, distintivo del suo grado, e forse aveva fatto bene, contando appunto su quel distintivo datogli dal re per farsi rispettare e anche temere.
Len-Pra invece indossava una graziosa casacchina di seta fiorata a ricami d’oro, stretta alla cintura da un’alta fascia, calzoncini di seta azzurra non così ampi come usano le nobili Siamesi, aveva sostituito alle scarpette degli stivali altissimi, di pelle gialla, e si era messa in capo un ampio cappello di paglia a forma di fungo, ornato d’un piccolo gallone dorato.
Prima di lasciare la phe, Lakon-tay aveva mandato il suo maggiordomo al palazzo reale con un messaggio per Phra-Bard, in cui lo avvertiva che, obbedendo ai suoi ordini, partiva per le regioni settentrionali del regno, alla ricerca del desiderato driving-hook.
Stavano per giungere sulla riva del fiume, dove il balon li aspettava, quando notarono presso la bellissima barca uno sconosciuto che stava chiacchierando coi battellieri.
Non pareva che fosse un siamese, quantunque ne indossasse il costume; aveva la pelle più fosca, la faccia più larga con una certa espressione di selvaggia ferocia, ed era forse più tarchiato e più robusto.
«Chi sarà quell’uomo che sta interrogando i vostri battellieri?» chiese il dottore, che, dopo l’aggressione notturna, era diventato eccessivamente sospettoso. «Non sarà uno dei vostri, suppongo.»
«Qualche curioso,» rispose il generale.
«Sapete perché vi ho fatto questa domanda?»
«No davvero, dottore.»
«Perché gli uomini che ieri sera mi hanno aggredito, avevano tutti quella taglia e quelle spalle così massicce.»
«Quel curioso mi sembra un malese.»
«Ebbene, se gli assalitori che tentarono di assassinarmi non erano Malesi, certo però che rassomigliavano.»
«Mi mettete addosso dei sospetti, dottore,» disse Lakon-tay. «Ora sapremo chi è quell’uomo.»
Lo sconosciuto, vedendo avvicinarsi il palanchino, cercò di allontanarsi dal balon, ma il generale con una mossa abile e pronta gli sbarrò la via, impedendogli di risalire la riva.
«Chi sei tu e che cosa volevi dai miei battellieri?» gli chiese con voce quasi minacciosa.
Lo sconosciuto, che dal tipo s’indovinava per malese, razza che si è largamente diffusa in tutti i reami indocinesi, guardò il generale con una certa sorpresa, poi rispose:
«Chiedevo se vi era un posto per me, mio signore. Sono un povero battelliere che cerca lavoro.»
«Interrogavi i miei uomini su altre cose, mi parve.»
«Chiedevo loro se andavano lontano.»
«Per incarico di qualcuno forse?» chiese il dottore.
Il malese lanciò sull’europeo uno sguardo fosco, poi alzò le spalle dicendo:
«Non so, frengi (europeo), che cosa tu voglia dire.»
Ciò detto, con un salto che dimostrava in quell’uomo un’agilità da scimmia, balzò sulla riva, allontanandosi rapidamente.
«Lasciate che vada a farsi impiccare altrove,» disse Roberto, vedendo il generale fare atto di inseguirlo.
Feng, che si trovava nel balon, era accorso.
«Che cosa chiedeva quel malese ai nostri uomini?» chiese Lakon-tay al fedele Stiengo.
«Cercava di interrogarli per sapere dove eravamo diretti, signore,» rispose.
«Glielo hanno detto?»
«No, perché ho tenuto nascosto a tutti lo scopo del nostro viaggio.»
«Sii prudente, mio bravo Feng,» disse il generale. «Non occupiamoci più di quell’uomo ed imbarchiamoci.»
Aiutarono a scendere Len-Pra, conducendola sotto il baldacchino di seta che si ergeva nel centro del balon, si sedettero accanto a lei sui soffici cuscini di seta cremisi e diedero il segnale della partenza.
Tosto le dieci pagaie, manovrate da dieci robusti garzoni, si tuffarono nell’acqua ed il balon si staccò dalla riva rimontando la corrente del maestoso Menam.
Nelle loro barche i Siamesi sfoggiano un lusso inaudito, e tanta è la loro passione per quei mezzi di trasporto, che non vi è famiglia, per quanto povera, che non abbia la sua imbarcazione.
Avendo nel loro paese degli alberi immensi, si servono dei tronchi di quelle piante per costruire i loro balon, i quali sovente hanno più di cento piedi di lunghezza. Sono però anche abili costruttori di navi, assai leggere, molto lunghe e strette ed eccellenti velieri, da preferirsi alle pesanti e tozze giunche dei Cinesi e dei Tonchinesi.
Il balon di Lakon-tay non aveva che cinquanta piedi di lunghezza, con una larghezza di dieci ed era stato scavato nel tronco d’un albero di tek, legno quasi incorruttibile e che può durare perfino un secolo, rimanendo sempre immerso. I costruttori gli avevano dato forme elegantissime e l’avevano, col ferro e col fuoco, reso leggerissimo senza comprometterne la solidità.
La prora, altissima ed affilata, reggeva una mostruosa testa di drago dipinta in rosso e giallo; i bordi erano scolpiti artisticamente e dorati; la poppa, un po’ meno alta della prua, era munita d’una specie di sedile imbottito, su cui stava il timoniere armato d’un lungo remo che doveva servire da timone.
Nel centro s’alzava un bellissimo cup, specie di baldacchino di seta a frange d’oro, sorretto da quattro eleganti colonnine dorate, e arredato con soffici cuscini pure di seta, bastanti per quattro persone e volendo anche per sei, e sui quali i padroni potevano anche coricarsi comodamente.
Ai due lati due parasoli di seta, distintivo di nobiltà, si ergevano per parecchi metri, l’uno color rosso, l’altro azzurro.
Dieci rematori, quattro a prua, seduti a due a due sui banchi, e sei dietro il cup, muniti di pagaie corte coi manici dorati, che immergevano perpendicolarmente, imprimevano alla leggiadra imbarcazione delle spinte vigorose, che la facevano filare come una scialuppa a vapore.
Erano tutti giovani, dalle membra poderose, dai muscoli sviluppatissimi, quasi nudi, non avendo indosso che un corto langut ed una fascia stretta ai fianchi che saliva fino alla metà del petto. Erano stati scelti con cura da Feng fra i numerosi schiavi del generale e si poteva contare assolutamente sulla loro fedeltà e sulla loro devozione.
Il balon, spinto da quelle dieci pagaie manovrate con energia, filò dinanzi al palazzo reale e alle colossali pagode che giganteggiavano sulla riva e ben presto si trovò fuori dalla città, fra due rive coperte da una lussureggiante vegetazione.
Numerose barche e anche dei balon s’incrociavano ancora, giacché il movimento fluviale è sempre vivo fino ad Ajuthia, l’antica capitale siamese. Più su s’arresta e cessa affatto oltre Na-kohn, giacché i Siamesi concentravano tutto il loro commercio nel basso corso del fiume.
Grosse barche, assai panciute, con vele formate da giunchi intrecciati strettamente e coperte da una tettoia, guidate solamente da un paio di battellieri, scendevano per trasportare alla capitale il raccolto dei campi; lunghissime canoe, montate da famiglie intere, cariche di frutta e di tuberi, s’incrociavano col balon, affrettandosi a cedere il passo alla vista degli ombrelli; gondole somiglianti a quelle veneziane, col rostro di legno anziché di metallo, radevano le rive.
Di quando in quando anche qualche cannoniera, di ritorno dai paesi settentrionali, passava rapida come una freccia, spinta da cinquanta o sessanta remiganti, che regolavano la battuta al suono d’una campana percossa dal comandante con un martelletto di legno. Erano belle scialuppe, di forme robuste, un po’ pesanti, scavate in un solo tronco di tek, e munite a prora d’un piccolo pezzo di cannone destinato a spazzare i pirati d’acqua dolce, anche allora non rari nell’alto corso del Menam.
Sulle due rive, lontane l’una dall’altra non meno di due chilometri, delle splendide vedute si offrivano agli sguardi del dottore.
Ora erano gruppetti di capanne, seminascoste fra mazzi enormi di bambù ondeggianti alla brezza; ora qualche pagoda dalla cupola slanciata, che rifulgeva sotto i raggi del sole come un blocco d’oro; ora erano invece risaie sconfinate sulle quali volteggiavano stormi infiniti di uccelli acquatici, e poi campi di canne da zucchero, piantagioni di pepe, gruppi e macchioni di banani, di palme svariate, di mangostani, di giganteschi durion i cui rami si piegavano sotto il peso delle grossissime frutta, irte di punte, ma contenenti una polpa deliziosa che se puzza d’aglio fradicio, si fonde in bocca come un gelato e ha il sapore di una crema squisitissima e profumata.
Di quando in quando, torme di bufali, dallo sguardo torbido e sanguigno e dalla fronte armata di corna enormi, guidati da un ragazzetto nudo come la mano, s’aprivano il passo fra le alte canne che ingombravano le rive, e s’immergevano nel fiume, divertendosi ad avvoltolarsi nel fango. Oppure si profilava improvvisamente, su quello sfondo verdeggiante, l’imponente massa grigia di qualche enorme elefante, occupato a saccheggiare le frutta degli alberi selvatici.
Sui sentieri costeggianti il fiume si vedevano invece passare drappelli di contadini carichi dei raccolti delle loro ortaglie, che canticchiavano allegramente; qualche talapoino dalle vesti gialle sdrucite, in cerca di questua; o qualcuno di quei bettolieri ambulanti di razza cinese che sono così numerosi nelle campagne Siamesi, tipi caratteristici e bizzarri, che portano la loro bottega appesa ad un bambù tenuto in bilico su una spalla: il fornello acceso sospeso davanti, ed una scatola a vari piani, contenente i tondi e le provviste, di dietro.